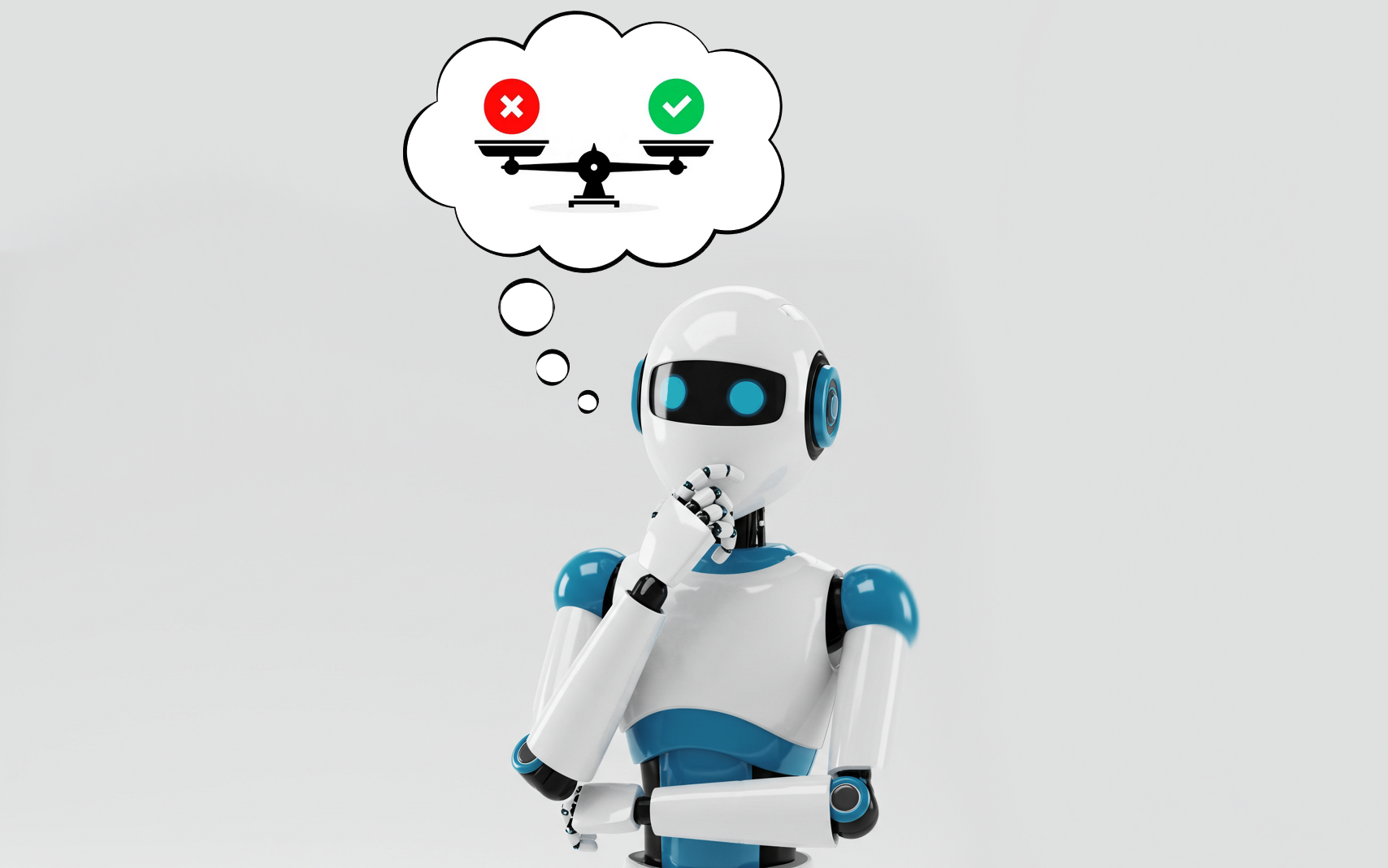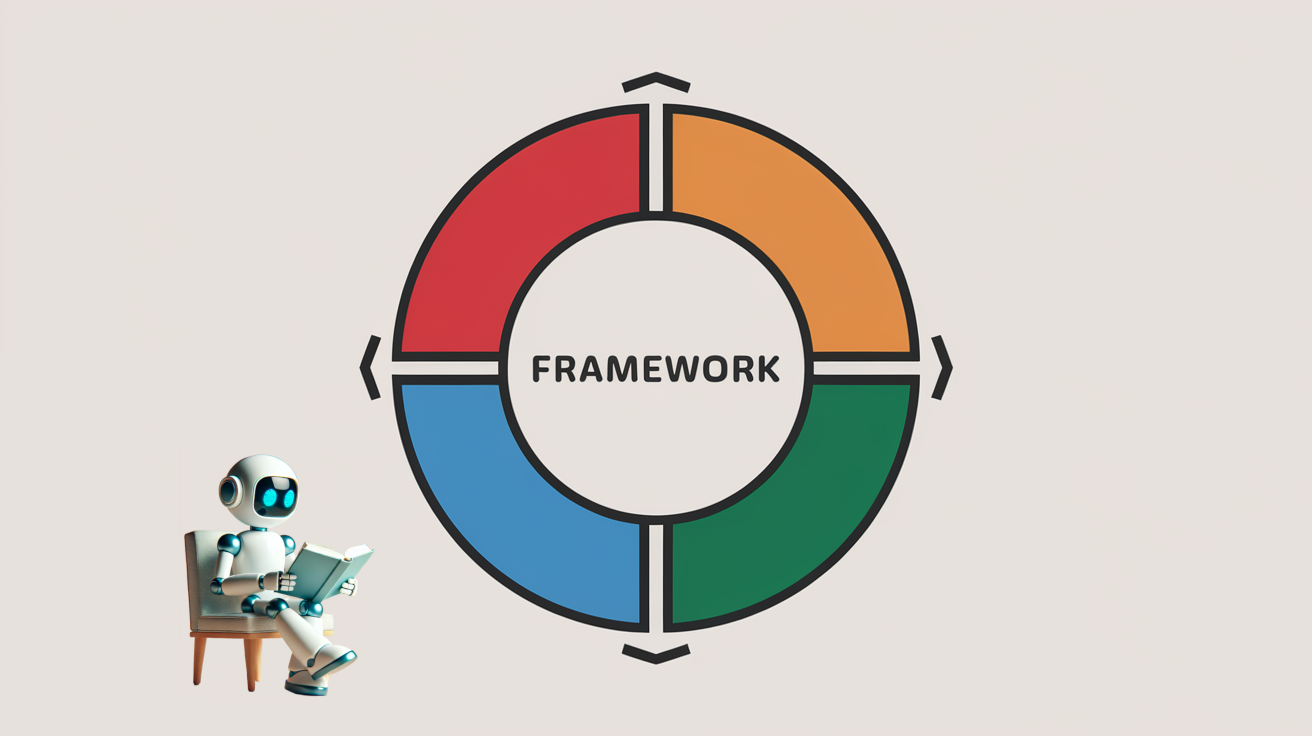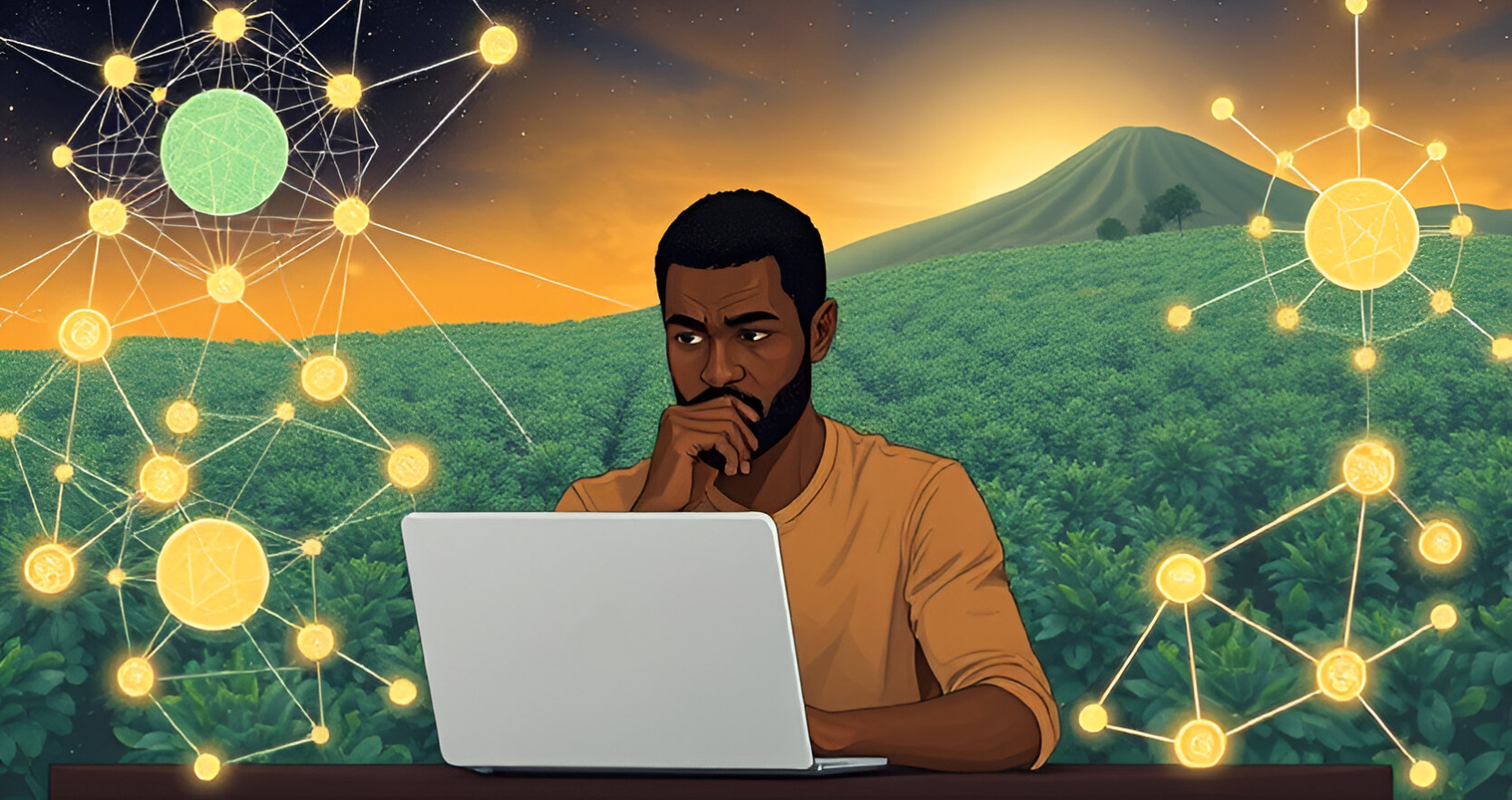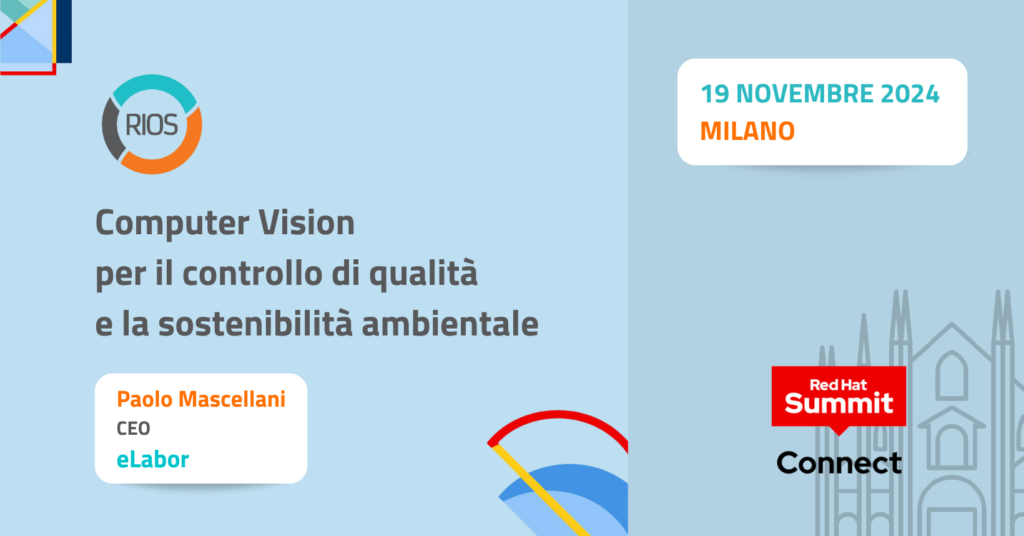Intelligenza Artificiale: tutti ne parlano, ma poco ne sanno
di Matteo Marcato
Dopo quasi due anni di tam tam mediatico, principalmente online, sono giunto alla conclusione che tutti parlano di qualcosa che non capiscono fino in fondo, ma in realtà nemmeno fino a metà e ho il fondato sospetto che una buona parte di questi “tutti” si sia fermato alla lettera A dell’alfabeto artificiale.
Fatta questa premessa poco edificante e non politicamente corretta nei confronti degli utilizzatori umani, tra i quali mi metto anch’io naturalmente, vorrei argomentare.
IA cosa significa
Intelligenza artificiale significa molte cose, ma almeno negli ultimi 12 mesi sembra si sia fatta largo, a senso unico, la definizione di un assistente in grado di generare qualunque cosa: testi, immagini, video e audio per riassumere e semplificare. Come il panettiere al quale un IT-manager sembra un hacker perché apre la pagina nera del DOS fin dagli anni 90 e scrivendo comandi come “ping” ottiene una risposta dalla macchina, allo stesso modo ai non addetti ai lavori del mondo artificiale (la stragrande maggioranza degli utilizzatori, tra cui chi scrive) l’IA sembra una black box magica.
Approfondendo le reti neurali e gli LLM si capisce che l’ingegno dietro le quinte è sempre umano, ma sono i risultati che contano e soprattutto conta che stupiscano, e ai più per la verità sembrano comunque frutto di riti esoterici.
IA non generativa
L’intelligenza artificiale però fin dalle origini non viene usata soltanto ad appannaggio della generazione di qualcosa. L’intelligenza artificiale è usata da molto tempo in vari ambiti per permettere alle macchine di “ragionare” e produrre risultati migliori.
Per esempio con tecniche di Machine Learning si insegna alle macchine a riconoscere oggetti, situazioni, errori. Quindi originariamente la sfera dell’artificiale declinata nell’ambito dell’intelletto si è sviluppata per aiutare l’uomo nelle situazioni in cui da solo fa fatica o non ci arriva proprio. Esattamente come le pompe idrauliche possono sollevare pesi immani, i motori a scoppio possono portarci a velocità inarrivabili e i computer possono fare calcoli a velocità mai vista, così l’ia viene da sempre studiata per favorire le attività umane, tipicamente del mondo produttivo.
IA nemica?
Con il diffondersi dell’IA generativa tra le masse però si sono aperti dibattiti, (probabilmente ancora pochi rispetto a quello che servirebbe), dove si tende a demonizzare la tecnologia o a esaltarla, in entrambi i casi le argomentazioni sono spesso superficiali, nel senso che si tende a restare in superficie e non si approfondisce mai davvero pro, contro, i come e i perché.
C’è chi si fa trascinare dall’entusiasmo e accoglie ogni novità, quasi quotidiana, con esplosioni di stupore e chi ad ogni passo avanti della tecnologia vedere futuri sempre più neri e distopici dietro l’angolo.
Chi ha ragione? Io non lo so, anche perché come vittima di un ottovolante tecnologico mi sento periodicamente sbalzato tra le due categorie, so però che certamente l’uomo della strada ne sa troppo poco e non c’è alcun interesse da parte di chi guida il vapore a fargli sapere di più.
Se guardiamo poi a chi legifera o ha un qualche potere decisionale tra le nazioni, pare che reciti la parte di quello che è arrivato in aeroporto un giorno dopo la partenza del volo, quindi sostanzialmente non prende parte a questo viaggio.
Noi da parte nostra dovremmo almeno fare lo sforzo intellettuale di capire se questa IA ci fa più bene o più male; fino a prima dell’avvento delle IA generative si trattava di una tecnologia come un’altra, che nasceva per favorire l’uomo e il lavoro, financo il divertimento: chi non ricorda videogame con un’IA rustica applicata ai nemici che potevamo fregare facilmente con qualche colpo di joystick e il suo miglioramento successivo nel tempo, che ci faceva invece penare per finire un livello.
Oggi e domani
Oggi le IA generative con le loro meraviglie, nonostante siano ancora allo stato embrionale tendono già a sostituire l’uomo, anche in ambiti in cui lui non ha mai chiesto di essere aiutato: disegnatori, scrittori, musicisti, registi, attori e potrei continuare molto a lungo, non hanno chiesto di essere clonati e sostituiti.
L’IA però vola e può sempre di più svolgere compiti non solo di fatica intellettuale ma anche creativa, in barba ad ogni regola, sia essa riferita alla privacy o al diritto d’autore per citarne un paio, tra l’altro. La domanda dunque è: possiamo farci qualcosa noi? Come ogni volta che ne scrivo nell’ultimo anno la questione finale mi lascia un retrogusto amaro, poiché non ho una risposta soddisfacente.
È come quando durante una dieta termini il pasto e ti convinci che in fondo un frutto è equiparabile ad un dolce, andiamo! Non puoi esserne davvero convinto…!
Credo che dobbiamo conoscere meglio sia cosa può fare sia come viene gestita, programmata, ingegnerizzata questa IA. Questo è quello che personalmente chiunque di noi può fare e poi quando la consapevolezza sarà maggiore si dovrà trovare il modo di usarla per migliorarci la vita e non peggiorarla, insieme ad istituzioni e legislatori. Obiettivamente però entrambe queste missioni le considero un filo utopistiche, anche perché in questo campo l’oggi è già domani e la velocità di evoluzione non è controllabile.
Allora tento una virata e mi butto sul confronto, mi piacerebbe sentire cosa ne pensano anche altri esseri umani su questo tema, a Chat-gpt ho già chiesto un’opinione in merito, ma ho il sospetto che sia un po’ di parte…!