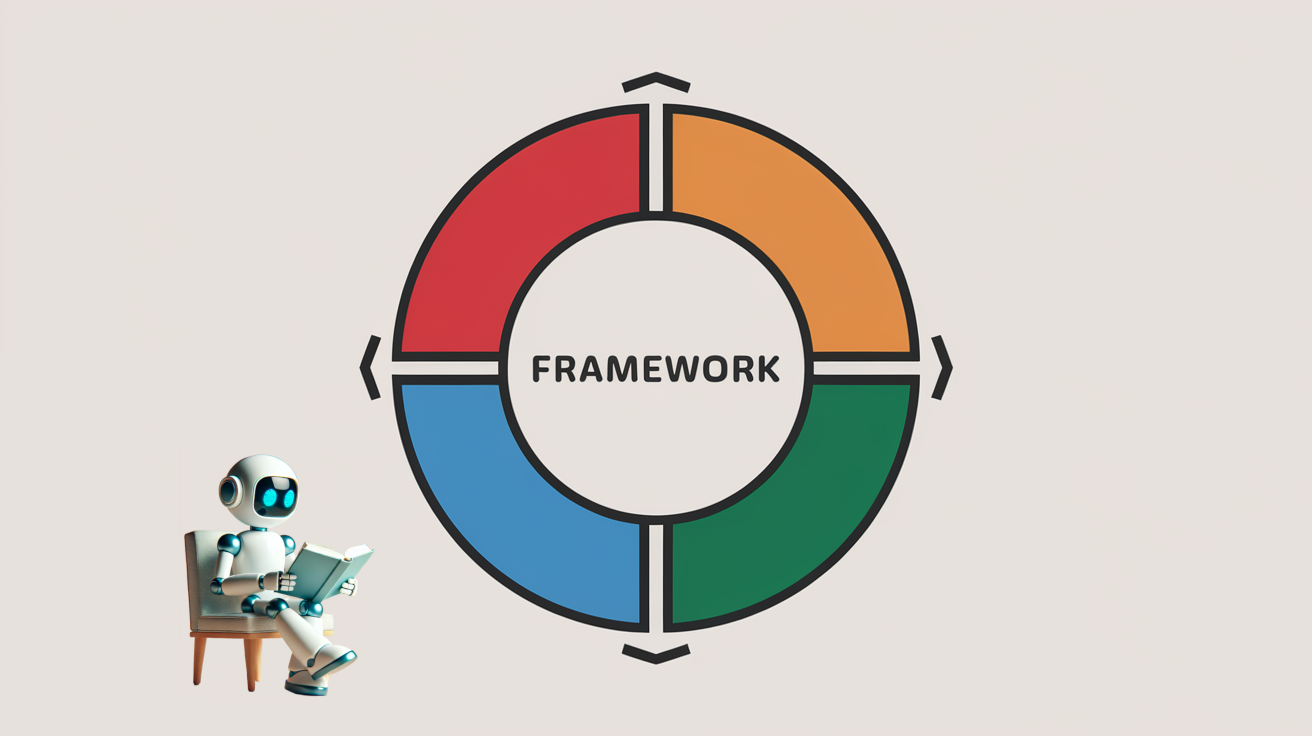Ci sono ricascato … ICT e AI in Africa
Ascolta l'articolo
Ci sono ricascato. Dove? In Africa, naturalmente: il vizietto non mi ha affatto abbandonato e, anzi,
sono sempre più coinvolto e convinto.
Un progetto che parte da lontano
No, non si tratta di caccia grossa, magari anche solo con la macchina fotografica: se volete capire un po’ meglio il mio approccio (che poi ho scoperto di essere quello di molti altri amici che sto imparando a conoscere), potete iniziare dall’articolo che ho scritto a marzo (https://www.adrflow.it/varie/sviluppo-intelligenza-artificiale-machine-learning-in-africa) per l’appunto appena tornato dal mio primo viaggio in Kenya di quest’anno.
Nel frattempo, però, le cose non sono state ferme: i contatti presi a marzo hanno dato i loro frutti, coinvolgendone altri, facendo meeting su Internet per fare brain-storming, organizzarsi, condividere idee di progetti, preparare la strada ad una nuova missione, che per l’appunto si è concretizzata alla fine di novembre. Troppo corta, purtroppo: gli impegni in eLabor, tra cui la partecipazione al Red Hat Summit Connect di Milano, appena prima di partire, e poi la necessità di chiudere delle attività prima della fine dell’anno, mi hanno lasciato solo 10 giorni (8 sul suolo keniano) per raccogliere i risultati del lavoro fatto ed impostare quello (tanto) ancora da fare.
Vi racconto chi ho incontrato…
Intanto, però, ho incontrato gruppi di persone eterogenei, ma molto determinati: come l’associazione delle donne e dei giovani della contea di Baringo, ad esempio, che stanno cercano di impiantare delle filiere produttive per i contadini ed i pescatori della zona e sognano di farlo con strumenti ICT ed AI innovativi, oppure i gruppi organizzati e le cooperative di contadini della contea di Vihiga, già decisamente più avanti nella realizzazione dello stesso sogno (non fatevi ingannare, se guardate qualche fotografia, dall’aspetto povero e dimesso: poveri sono, ma il cervello ce l’hanno fino, ve l’assicuro, così come non manca certo loro la determinazione).
Poi ho incontrato i gesuiti di Nairobi, che stanno organizzando un corso di laurea che contribuirà alla formazione dei nuovi manager di cui il Kenya ha bisogno per far decollare la propria capacità di dare lavoro, beni e servizi di qualità a persone, imprese e pubbliche amministrazioni. Non per niente, è nato anche uno “spin-off” che punta a diventare un Digital Hub e col quale abbiamo iniziato a progettare le modalità per la nostra collaborazione prossima futura. Infine, altri imprenditori coi quali attivare proficue collaborazioni per entrambi.
e quello che ho notato
Sono state tutte occasioni in cui ho potuto verificare come l’approccio che ho descritto nel mio ultimo articolo (https://www.adrflow.it/uncategorized/framework-per-progetti-ict-ai-mettere-i-problemi-al-centro/) sia da una parte fondamentale e dall’altra abbia in sé la capacità di motivare tutti questi gruppi di persone, pur così eterogenei: naturalmente, ciascuno secondo la sua preparazione ed il livello di sviluppo del suo progetto.
Una cosa che ho notato e che anche quelli che sono più lontani dalla meta, dopo un primo momento in cui hanno avuto una reazione del tipo “non pensavo che fosse così difficile”, hanno capito che sicuramente è impegnativo, ma è anche possibile e, anzi, avere una buona metodologia, che non nasconde gli ostacoli, ma che predispone le cose per il loro superamento, è molto stimolante e promettente.
Ci sono poi altri avvenimenti che sono successi dopo il mio ritorno e che mi hanno ancora più convinto della bontà di questa scelta di guardare a sud, ma ve ne parlerò in un prossimo articolo; per il momento state sicuri: il continente africano ed il particolare la zona dell’Est Africa ce ne faranno vedere delle delle belle nei prossimi anni!
Paolo Mascellani